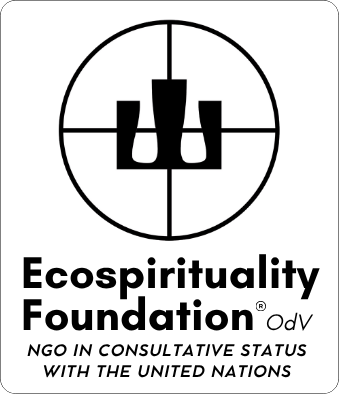| Società |
La Cattedrale di Montagna |
 |
 |
| 23 Gennaio 2014 | |||
Una missione umanitaria in Kenya
Un viaggio che comincia con compagni inattesi ha il sapore delle scoperte monumentali. Fu così che salii su un taxi una mattina qualunque di inizio settembre. L’atmosfera di Torino-Caselle mai come quel giorno mi è sembrata nuova, accesa dai colori che hanno solo le aspettative più belle. Pochi istanti sono bastati per materializzare lo scalo parigino. Un groviglio di persone dirette verso ogni meta conosciuta. Tuttavia quegli spazi mi sono apparsi da subito familiari, come se il percorso fosse tracciato già da tempo. Mentre pensavo ai miliardi di individui che incrociavo, alle loro storie ed alla loro destinazione, sono inciampata nel terzo viandante di questo cammino idealizzato. Ad un chiosco carico di crudité ho udito una voce che chiamava per nome il mio Professore, era il terzo componente della truppa italiana. L’urologia è una professione, ma a volte può diventare un’incantevole vocazione. Otto ore di volo ci avevano separato dal nostro Paese ed uniti ad un mondo che non ci appartiene ma che ci strega come nessun altro. Siamo atterrati una sera piovosa in un aeroporto sgangherato fatto di baracche e di musica improbabile che decorava gli spazi come un mobile barocco in una capanna di fango e paglia. Milioni di uomini sperduti come noi, a compilar cartacce di un’inutile burocrazia, ore di attesa per pagar pochi dollari, tassa d’ingresso in un paese senza vincoli. Così apparvero i primi individui che popolano i miei ricordi. Due giovani sposini italiani, forse sperduti più di me, in attesa di un visto che decretava l’inizio del loro cammino insieme. Io ricordo, li guardavo con un briciolo di ossessione e pensavo al mio viaggio, ai suoi grandiosi obiettivi. Uscita dalle ormai noiose tende dell’aeroporto ho trovato ad accogliermi un’aria fredda che percorreva una strada male asfaltata, brulicante di gente chiassosa. Sul confine dell’aeroporto era il mio Professore ad aspettarci, affiancato da una improbabile compagnia fatta di suore e di un autista, Dominique, scuro come la notte, con gli occhi amichevoli come quelli di un premuroso fratello. Ci siamo immersi nella città addormentata a bordo del nostro fedele pulmino. Era sporco, angusto, minimale, ogni frenata si percepiva come un colpo dato ad un muro precario. Una delle case delle suore di Nairobi ci ospitò quella notte. Il riposo trascorse placidamente, con la pancia quietata da una macedonia intensamente profumata di mango e banana.
Il risveglio mattutino fu alle 7 come tanti altri, eppure totalmente diverso perché i miei occhi hanno incontrato volti nuovi e inattesi. È ora che inizia il vero viaggio verso la Cattedrale di Montagna. La prima sosta la facemmo ad una cadente pompa di benzina. In quel posto solo la polvere regnava sovrana ed io incredula mi chiedevo cosa diavolo ci facessi lì, con gli occhi tinti di quello sdegno tipico degli occidentali alla scoperta della Terra Nera. Da quel momento in poi le ore sono trascorse come minuti e la truppa Italiana in un istante si è ritrovata alle porte della meravigliosa Cattedrale di Montagna: North Kinangop, un ospedale-comunità a 130 km dalla capitale, arroccato su di un altopiano a 2500 metri sul livello del mare. Io, cocciuta, ancora non avevo perso la mia superbia cittadina e mi chiedevo come fosse possibile vivere senza riscaldamento, asfalto, cinema, abiti da cocktail, aperitivi. Entrai in quella che sarebbe stata la mia stanza per due settimane e capii che tutto quello che ritenevo indispensabile in realtà era solo uno colorato, inutile accessorio. Lì c’è poco spazio per i convenevoli ed il riposo, il nostro benvenuto si limitò ad una stretta di mano ed una frugale colazione. Il caffé offerto da suor Norberta prima del doveroso ambulatorio mattutino mi scese in esofago ancora con una certa difficoltà, la ritrosia verso l’ignoto è difficile da vincere. Lo confesso, non capivo cosa mi avesse spinto a fare tanta strada, però il mio Professore interrogava, voleva sapere cosa provavo, ed io orgogliosa, non potevo che negare il mio evidente ed infantile imbarazzo. Questi pensieri sono trascorsi in un lampo, spezzato da quel camice troppo largo che la Suora mi mise fra le mani: “bene, iniziamo a lavorare? Perché qui, Francesca, si lavora tanto sai!”. La giornata è trascorsa operosa, i passi di noi tutti scivolavano abilmente fra ambulatori, reparti e sala operatoria, come se lavorassimo lì da un tempo indefinito. Non era solo l’ospedale, non solo la chiesetta e le case di chi li viveva, le stalle, i campi, il fornaio, in quel luogo c’era davvero tutto quello che serviva per vivere. Quella piccola comunità era, a modo suo, il regno di un ordine imperfetto ma incrollabile che guidava le attività quotidiane. Noi da quell’ordine così poco occidentale ci siamo fatti trascinare, abbiamo imparato a rispettare i tempi e le necessità di un piccolo pezzetto di mondo che ci aveva fatti suoi senza chiederci il permesso.
Gli ambulatori erano una ordinata fila di piccole stanze, fredde e scarne, ma nelle quali (mi sembra una distorsione della mia fantasia) non mancava mai nulla di essenziale. La scrivania era in gran parte occupata da un grosso librone che fungeva da antiquato registro di accettazione, su di questo annotavamo scrupolosamente i nostri pazienti. Ricordo la curiosità che mi suscitava sbriciare fra quelle pagine piene di nomi che faticavo a leggere e di medici italiani che avevano già fatto quello per cui mi trovavo li. In quei momenti capivo di essere stata molto fortunata. Delle ore trascorse a visitare in una lingua non mia il ricordo più invadente di tutti sono gli occhi delle persone che sfilavano davanti a me, tutti carichi di una dignità quasi aristocratica. Difficile non vedere un sorriso sui quei volti, ancora più difficile era sentire un lamento ed allora la voglia di far al meglio diventava un’ossessione. Come potevo sbagliare con persone che mi avrebbero detto in ogni caso Grazie? Con una disinvoltura sconosciuta ai nostri moderni Ospedali, i nomi passavano da quel registro al lettino della sala operatoria e le nostre mani, illuminate dalla scialitica, si muovevano incessantemente in un modo che io non credevo neppure potesse appartenermi. Non ricordo giorno in cui non ci sia stato, da parte di noi tutti, il profondo desiderio di portare a termine la nostra Missione. Non ricordo momento in cui la stanchezza abbia preso il sopravvento, ogni passo che facevo non era energia spesa ma guadagnata. Nelle due settimane trascorse tutto ciò che mi circondava aveva l’alone sfumato della magia, sapevo sarei tornata alla mia solita cara vita, sapevo che si trattava solo di una bella parentesi, ma mi divertivo ad immaginare che quella parentesi fosse stata aperta proprio per noi. Non voglio dilungarmi sulle gioie della chirugia, quelle restano private e gratificanti solo per la sottoscritta. Voglio però chiudere gli occhi alcuni istanti per farmi cullare dalla magia delle buie notti kenyote, basta una fugace distrazione per rivivere intensamente il loro profumo. Ricordo il manto stellato che imprigionava i nostri sguardi, in quel silenzio così poco umano, abbracciati dalla gelida brezza che avvolgeva la Cattedrale. Eravamo tutti lì, come amici di lunga data, a raccontarci il nostro cammino e a rivivere quei giorni trascorsi assieme, comprendendo appieno che le emozioni di tutti erano vissute col cuore di uno solo. L’avventura si è conclusa nel medesimo aeroporto, fatto di musica, colori e tendoni improvvisati. Ciò che resta di materiale è un filo di pietre colorate, opera delle donne Masai, a decorare il mio collo nella quotidianità torinese. Nella sua grandiosa semplicità si racchiude il Mio Kenya. Hakuna matata! (antico saluto Kenyota)
|
 -->
-->