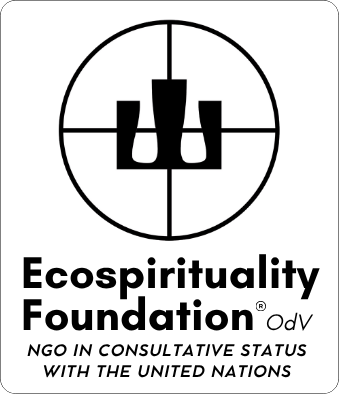| Leggende e Tradizioni |
Il mistero delle Vergini Nere |
 |
 |
| 25 Marzo 2020 | ||||||||||||||||||||
La Madonna Nera di Forno Alpi Graie e il suo contesto storico-culturale
Avevo sentito parlare fin da ragazzo, essendo Forno Alpi Graie il mio paese d’adozione, della vicenda di Pietro Garino, della sua miracolosa visione e della nascita del Santuario, ma ne avevo una conoscenza estremamente superficiale, limitata ai racconti della tradizione. Quando ho incominciato ad analizzare l’avvenimento secondo criteri storici ed antropologici, la realtà si è rivelata variegata e complessa, ben oltre quanto potessi immaginarmi. Il lavoro di studio è stato appassionante per i suoi risvolti inaspettati e per le molteplici diramazioni, ma le conclusioni non hanno sciolto gli enigmi. Alla fin fine i perché fondamentali non hanno trovato risposta, se non molto approssimativa, poiché tutti i racconti di fondazione si basano sulla tradizione orale e non su documenti. Ma almeno il contesto è diventato più visibile. Rimane la soddisfazione della ricerca: diceva Lessing che la caccia val meglio della preda. Ringrazio tutti gli studiosi che mi hanno generosamente aiutato con notizie e suggerimenti. Qualche notizia su Forno Il villaggio di Forno Alpi Graie (m. 1227) sorge in una vasta conca glaciale alla testata della Val Grande di Lanzo, presso il torrente Stura, che tanti danni ha provocato nel corso del tempo, e costituisce l’ultima frazione di Groscavallo. Fino al 1928 era stato Comune autonomo. L’unione con l’attuale capoluogo non fu certo vista di buon occhio, a causa di antiche rivalità. Ad esempio, già intorno al 1650, era scoppiato un forte contrasto fra i due paesi per l’utilizzo della miniera di Rambeisa (o Rambasa), da tempo abbandonata, probabilmente dopo una delle tante alluvioni o una delle frequenti pestilenze, che sottraevano manodopera. Tra l’altro, proprio in occasione dell’epidemia del 1522, a Campo della Pietra fu costruita, per voto, la cappella dell’Annunziata, che, pur fatiscente, è la più antica del Comune. Groscavallo voleva riattivare Rambeisa e costruire una casetta per i minatori, per cui chiese un contributo in denaro e lavoro a Forno. Quest’ultimo rifiutò, e fu la rottura. Una delle tante guerre fra poveri. Secondo antichi documenti notarili, tra i Fornesi v’era chi, come Pietro Garino (di cui parleremo), consigliava di rinunciare e limitarsi ad utilizzare il giacimento di Rognosa ( o “miniera del pane”), a tutt’oggi non individuato. Il toponimo diventò poi “Rignousa”. Così Rambeisa rimase a Groscavallo, che estese i propri confini al di là dello spartiacque del monte Barruard e dovette realizzare un altro tracciato, affinché i muli portassero il materiale ai nuovi forni del sottostante villaggio di Pialpetta. Ma questo non fu l’unico motivo di contrasto. Già nominato in documenti del XIII sec., Forno era nato come centro metallurgico (il nome stesso lo indica) ed aveva raggiunto un buon livello di sviluppo. E’ vero, però, che la tremenda alluvione del 1585 aveva distrutto quasi per intero il paese e le sue officine, tanto che l’abitato fu ricostruito più in alto, in posizione più sicura, al riparo della rupe del “Roc Pendü”. Successivamente si verificò una ripresa, ma soprattutto nacque, grazie a Pietro Garino, il celebre Santuario della Madonna Nera, che attirava migliaia di pellegrini. Ce n’era abbastanza perché Forno reclamasse il distacco da Groscavallo, che ovviamente si opponeva, poiché la parrocchia non voleva perdere la propria fetta di introiti. Finalmente, dopo lunghe diatribe, fra il 1756 ed il 1757, Forno fu accontentato e, da cappellanìa, divenne parrocchia.
Più complessa è la questione dell’autonomia comunale. Il paese, che fu denominato all’origine Forno di Groscavallo, aveva un proprio sindaco ed un’ampia facoltà di autogoverno, ma restava vincolato appunto al capoluogo storico. Perciò un altro motivo di contrasto con quest’ultimo era la ripartizione dei versamenti dovuti al governo ducale. Groscavallo pretendeva che ne fornisse un terzo proprio Forno, il quale, invece, voleva pagare in base ai “fuochi”, cioè ai capifamiglia. Fu una lunga ed alterna lotta, a suon di carte bollate e ricorsi alle autorità superiori. A metà ‘800 i Fornesi respinsero sdegnosamente una richiesta governativa di fusione, aggiungendo “Alpi Graie” al nome del loro paese. L’attività mineraria attraversò fasi alterne: a periodi di chiusura seguivano altri di ripresa, specie in occasione di guerre, allorché con il ferro locale si producevano palle di cannone. E’ quanto accadde ancora ai primi del ‘700 durante il conflitto con la Francia. La presenza di miniere attirò nelle Valli di Lanzo, e perciò anche a Forno ed a Groscavallo, della manodopera straniera, persino dalla Val Sesia e dal Bergamasco e dal Bresciano. I nuovi venuti, talvolta, costituirono gruppi a sé nei paesi d’adozione, come a Forno di Lemie, dove gli emigrati conservarono il proprio dialetto. A Forno Alpi Graie, ad esempio, arrivò gente di varia provenienza ed è verosimile che, tra le altre, ad un certo punto sia giunta, spinta da motivi economici, anche la famiglia dei Garino, attestata in antico tra Torinese e basso Canavese. La sostanziale povertà dei giacimenti in rapporto alle accresciute esigenze moderne, o addirittura il loro esaurimento, le difficoltà di accesso e la carenza di combustibile per i forni, il massiccio disboscamento (verificatosi, a quanto risulta, anche nella fornese Val di Sea), portarono alla cessazione definitiva dell’attività. Forno dovette convertirsi ad un’economia di tipo agro-pastorale, che però non copriva i bisogni della popolazione. I fitti boschi di oggi nasconodono, sui pendii, i muri di pietra delle cenge costruite anche nei punti più impervi, per ricavare un po’di terreno coltivabile. Si accentuò così il fenomeno dell’emigrazione stagionale (o definitiva), diffusa già prima di allora, come dimostra, lo vedremo, il caso di Pietro Garino stesso. Erano soprattutto gli uomini ad andarsene: quelli di Forno, Goscavallo e Chialamberto facevano la “stagione” a Torino o in altri centri della pianura, soprattutto come salcicciai o agnellai (ma non era il caso del Garino) oppure si trasferivano in Francia nelle miniere o nelle cave di ardesia. Invece le ragazze si impiegavano talora come “servente”, ma, se restavano in paese, quelle di Forno, per fierezza, raramente sposavano qualcuno delle borgate sottostanti. Comunque i più, in estate, tornavano in paese per la fienagione ed i lavori agricoli. L’emigrazione temporanea fu attuata soprattutto dagli abitanti dell’alta valle. Questi, secondo tradizione, venendo a contatto con la città o paesi stranieri, divennero più evoluti culturalmente. Questo tipo di economia, un po’ in tutto il Piemonte, è finito con l’industrializzazione del secondo dopoguerra. Per Forno, che ai primi anni ’50 contava ancora una cinquantina di abitanti ed era parrocchia, il dissolvimento è stato totale. Con lo svuotamento del borgo si sono perse una cultura ed una lingua, che erano particolarissime per scelta degli abitanti. I Fornesi ne erano orgogliosi, le sentivano come un mezzo di differenziazione, non solo geografica, rispetto agli altri villaggi. Dell’antica comunità è scomparso, si può dire, perfino il nome: il cartello stradale all’ingresso del paese recita “Fuorn”, il termine usato in valle, e non l’originario “Forn”. I “luoghi” del Santuario di Forno Il Santuario di Forno sorge su un ripido pendio boscoso all’imbocco della Val di Sea, un imponente solco glaciale che si prolunga sino al confine con la Francia. Incassata e severa nel tratto iniziale, delimitata da pietraie e pareti strapiombanti, tale da risultare sgradevole a molti escursionisti, questa valle era un tempo il principale corridoio di accesso alle regioni transalpine. Il Santuario sembra esserne la sentinella. Tutto il versante che scende dalle cime sovrastanti della Leitosa e del Bec ‘d Mesdì è estremamente ripido ed aspro: vi si alternano tratti scoscesi di bosco fittissimo, rupi, colate di massi. Su questi pendii selvaggi non ci sono pianori adatti al pascolo. L’unico era Pian ‘d Rignousa (riecco un nome già menzionato), un modesto terrazzo prativo sopra il Santuario, oggi invaso dalla vegetazione. Vi si arrivava con un sentiero, ormai scomparso, che aggirava l’area dell’edificio sacro e conduceva poi alla lontana alpe di Leitosa. Quindi chi risaliva questi pendii poteva solo andare in cerca di legna o di fogliame per la lettiera del bestiame. Infatti anche il bosco dell’attuale Santuario, fino agli anni ’50 del ‘900, veniva messo all’incanto, a lotti, per la raccolta di foglie (soprattutto di faggio) per lo strame.
A sinistra del Santuario (per chi guarda dal basso), a poca distanza dall’area sacra, si apre un impervio canalone che taglia l’erto pendio in tutta la sua lunghezza. Spesso, in inverno, vi precipita un’imponente valanga, che regolarmente falcia la boscaglia. E’ il “Cinai d’la Madona”. Lo percorreva la gente della Val d’Ala per scendere al Santuario in occasione delle feste del 15 agosto o dell’8 settembre. Raggiungevano con un lungo cammino il Colle del Trione, attraversavano la conca dei laghi e salivano al collarino fin presso il Bec ‘d Mesdì, dove li attendeva un’impressionante discesa. Naturalmente, oggi, la via è quasi impraticabile. Va rilevato che tutto il pendio montuoso fino a Campo della Pietra è solcato da questi canaloni da valanghe (Cinai d’l’Ours, Cinai di’Merlou, Cinai Grand), che ne accentuano l’aspetto selvaggio . Visto dal basso, dal versante opposto della valle Sea, il Santuario appare schiacciato contro la montagna. Ci si chiede come esso abbia potuto trovare posto in un’area così scoscesa, dove all’erta boscosa si alternano tratti di nere rupi gocciolanti. Ma, contigua all’edificio, sgorga una sorgente perenne. Le fonti erano uno degli elementi sacri per eccellenza presso gli antichi. Gli anziani di Forno consideravano miracolosa quell’acqua. Ricordiamo, poi, che la Vergine e le due donne della visione di Garino apparvero su un masso in forte pendenza (forse, poi, spianato e inglobato nelle fondamenta dell’edificio), e anche questo è un elemento tipico della religiosità primitiva. L’attuale Santuario sorge addossato ad una nera roccia che forma un ampio, umido, incavo, e la grotta è un altro topos degli antichi culti pagani. La leggenda racconta che qui, ben prima della visione di Garino, si fosse stabilito un santo eremita, il quale, esistito o no, potrebbe simboleggiare un primo tentativo di cristianizzazione del luogo. E’ probabile, comunque, che in quest’area sacra fosse stata aperta una piccola radura, sufficiente poi ad ospitare la modesta cappella fondata da Garino. Per il successivo, importante, ampliamento fu necessario un massiccio sbancamento, per disporre di uno spazio maggiore. Infine sussiste un ulteriore dato da considerare. Quando stilò il suo primo testamento, nel 1651, Garino stabilì che il bosco sottostante la cappella dovesse restare intatto, che non si tagliasse nemmeno un albero né si permettesse il pascolo delle capre. In una zona come Forno, dove il disboscamento era un uso comune per procurare combustibile all’attività metallurgica, questa scelta, sempre rispettata da chi venne dopo di lui, quanto meno stupisce. E’ improbabile che il posto fosse circondato da una semplice boscaglia e che si volesse salvare proprio quella. Doveva trattarsi di tronchi già imponenti, che costituivano un valore morale e religioso, sopravvissuti perché l’area era stata sacralizzata già in precedenza, in epoca pagana. Alla luce degli studi antropologici recenti, che contemplano molti casi analoghi, si può quindi concludere, come ribadiremo più avanti, che la vicenda di Pietro Garino e della nascita del Santuario costituisca un intervento di cristianizzazione di un sito pagano. Il contesto storico La montagna è sempre stata un ambiente difficile. Al problema cronico della scarsità di risorse veniva spesso a sovrapporsi la catastrofe delle alluvioni, che si susseguivano con notevole frequenza, devastando i prati ed i campi strappati con fatica ad un territorio avaro, distruggendo le attività economiche, come fucine e mulini. I documenti storici testimoniano una continua sequela di richieste ai sovrani, da parte delle popolazioni, di remissione delle tasse (quando era concessa, però, la “grazia” era definitiva e della durata di vari anni; non si doveva pagare “poi” come succede ai terremotati di oggi) e di rimisurazioni catastali per determinare i confini cancellati. Una delle più terribili per Forno fu quella del 1585, che travolse gran parte del paese. Essa non fu un caso: tra la fine del ‘500 e gli inizi del 1800 circa fu in atto quella che gli studiosi chiamano “Piccola era glaciale”, che comportò un forte peggioramento del clima in tutta Europa. Nel 1640 due immani frane, provocate dalle piogge, travolsero e sommersero le borgate di Teppe (non lontano da Forno) e Ciansea (presso Groscavallo). Ma le alluvioni rimasero una costante delle nostre montagne. Ancora nel secolo XX, mi raccontava, a titolo di esempio, un anziano di Forno che, dopo l’ennesima inondazione, ad una famiglia povera del paese era stato assegnato un terreno, distrutto dal torrente, che essa aveva “ricostituito” a prato andando a recuperare zolle d’erba nei posti più impervi della montagna. Ed è superfluo ricordare la sciagura abbattutasi su Forno nel 1993.
Alle calamità naturali si aggiunsero, in passato, quelle provocate dall’uomo. Il ‘500 ed il ‘600 furono secoli di continue guerre, che comportavano, di per sé, contributi in denaro da parte delle popolazioni, gravose esazioni di vettovaglie e bestiame, alloggiamento e mantenimento delle truppe. Francia e Spagna, per assicurarsi il controllo dell’Italia, scatenavano le loro soldatesche, che saccheggiavano ovunque passassero e recavano con sé, come inevitabile conseguenza, la peste. Pertanto le epidemie si susseguivano con la stessa frequenza delle alluvioni. Il Piemonte si trovò ad affrontare situazioni particolarmente difficili, anche a causa della bellicosa e scriteriata politica del duca Carlo Emanuele I, specie durante le due Guerre di Successione al trono di Mantova e del Monferrato (1612-17 e 1627-31), con pestilenze che falcidiarono la popolazione. Le milizie mercenarie non risalirono, per fortuna, le valli di Lanzo, i cui aspri valichi non consentivano il passaggio di grandi eserciti, ma gravarono ugualmente con l’imposizione di forniture sulle popolazioni e, appunto, vi propagarono il morbo. Ma non fu solo il Piemonte ad essere colpito; ad esempio proprio dalla Lombardia, invasa dai Lanzichenecchi, partì la terribile pestilenza del 1629-30, descritta dal Manzoni, i cui effetti si diffusero a ventaglio. Tra ‘500 e ‘600, inoltre, le guerre si intrecciarono con i conflitti religiosi. La Controriforma scatenò la lotta contro gli eretici e contro le streghe, toccando anche le Valli di Lanzo. Questa condizione disperata generò, verosimilmente, un’accresciuta domanda di religione, sentita come indispensabile conforto nelle sciagure. Apparizioni e miracoli diventarono più frequenti, e con essi nacquero piloni, cappelle e santuari. Nel 1610, a Lanzo, si erano stabiliti dei Gesuiti, chiamati da un gentiluomo di corte di origine lanzese, per diffondere, attraverso la predicazione, la religione nelle Valli, dove essa era in crisi per “mancanza di mezzi”. Ma non è “pensar male” se si ipotizza che fossero stati chiamati, in tempi di Controriforma, per esercitare un controllo anche sull’insorgere di eresie, come era diventato loro compito specifico. Non va dimenticato che, nel corso del ‘400, a più riprese, nelle vallate lanzesi un buon numero di persone era stato processato ed arso vivo, per cui il sospetto restava. Nel 1618, quando la peste era stata portata dai soldati francesi, e quindi in un clima di grande preoccupazione, i Gesuiti incitarono la gente di Lanzo a rivolgersi alla Madonna e proposero di realizzare in suo onore una cappella sul modello della casa di Loreto, di cui ricorreva l’anniversario di costruzione. Ricordiamo che questo ordine sacerdotale era diventato il principale sostenitore della causa lauretana. L’invito fu accolto entusiasticamente dalla popolazione, non solo lanzese, così fortemente provata. Le offerte in denaro, materiali e manodopera furono notevoli (la gente andava a prelevare sassi e sabbia nell’alveo della Stura) e in tre mesi la cappella fu realizzata, in regione Braide, ed inaugurata con una Messa il 15 agosto. Quello fu un caso atipico: la nascita di un Santuario per un intervento “dall’alto”, e non indotta da un’apparizione o miracolo a livello popolare. Da allora Lanzo esercitò la sua forza di irradiazione nella pianura e nelle valli soprastanti. L’anno dopo, in località Prascondù di Ribordone, nella contigua Valle di Locana, la Vergine apparve ad un pastorello (Giovannino Berrardi), che era diventato muto, e lo sollecitò ad effettuare il pellegrinaggio a Loreto, promesso in voto dal padre, nonché a costruire una cappella in suo onore. Sulla via del ritorno il ragazzo guarì e il fatto suscitò scalpore. La gente accorreva sul luogo dell’apparizione e l’edificio sacro fu realizzato in fretta, tra il 1620 e il 1621. Intanto sul Monte Bastia, vicino a Lanzo, i lupi che infestavano la zona erano diventati sempre più minacciosi. L’invasione si fece intollerabile intorno al 1626. Si effettuarono novene e processioni invocando Sant’Ignazio di Loyola (ritengo sia ragionevole pensare ad una regia dei Gesuiti di Lanzo) e i lupi si ritirarono verso l’alta montagna. Dopo il miracolo il Santo apparve ad una coppia di montanari di Tortore. In conseguenza dell’intera vicenda, tra il 1628 ed il 1631, fu costruita sul monte Bastia una cappella, la quale costituì il primo nucleo dell’attuale, imponente, Santuario che domina sulla bassa Valle.
Osserviamo, in margine, che la Lombardia, proprio in quegli anni, non fu da meno in tale gara di apparizioni e di fervore religioso. Ad esempio, a Imbersago, presso Lecco, dal 1615 in poi si diffusero voci di apparizioni della Vergine nei dintorni della Sorgente del Lupo, presso la quale erano situati tre grandi castagni (riecco gli elementi tipici , acqua ed albero, degli antichi culti pagani). I lupi, appunto, infestavano la zona. Nel 1617 qui ebbero una visione mariana tre pastorelli. La gente accorse per venerare la Madonna e poco dopo si decise la costruzione di una cappella. Era un periodo di invasioni, peste e siccità. L’edificio fu terminato nel 1632, quando le cose volgevano al meglio. Non resta che aggiungere a tale elenco la vicenda di Pietro Garino e della costruzione del Santuario di Forno e il quadro si completa. Le apparizioni ed il fervore religioso rispecchiavano sicuramente le disperate esigenze delle popolazioni in quella drammatica epoca storica, in cui il sacro costituiva l’indispensabile rifugio. Non è un caso, secondo me, che un’altra fioritura di santuari, come il Colombardo, gli Olmetti, Marsaglia si sia verificata ai primi del ‘700, in piena Guerra di Successione Spagnola, quando le armate francesi invasero il Piemonte e giunsero ad assediare Torino. Pietro Garino Di Pietro Garino, il protagonista dell’erezione del Santuario di Forno, non abbiamo molte notizie; ignoriamo, ad esempio, la data di nascita. Da un atto notarile del 1619, relativo ad una divisione di beni, risulta che egli fosse stato citato in qualità di testimone in una causa legale. Come tale, per legge, doveva avere almeno venticinque anni e perciò essere nato, probabilmente, intorno ai primi anni ’90 del ‘500. Tali dati, come quelli che seguono, sono frutto delle pazienti ricerche di Maria Teresa Serra, una delle più attente studiose della storia locale del Lanzese. La presenza dei Garino, a Forno, è registrata dal 1550 circa. E’ probabile che fossero giunti, forse dal Torinese, per impiegarsi nel settore minerario o metallurgico, che attirava una frequente migrazione di manodopera. In un atto risulta che uno di loro cedette parte dei propri diritti di sfruttamento ad un Venera (quindi non dovevano essere semplici operai). In un documento del 1597, che riporta i nomi dei possidenti del paese, risultano presenti ancora tre “fuochi” dei Garino, ma ai primi del ‘600 ne resta uno solo. Era quello principale, visto che, nell’albero genealogico, di nonno in nipote, si nota l’alternanza costante dei nomi Pietro-Giacomo, Pietro-Giacomo. Dunque il nostro protagonista si chiamava come il nonno. In sostanza le altre due famiglie, come tante di Forno, dovevano essersene andate, forse per le conseguenze della tremenda alluvione del 1585 (ma se ne verificò un’altra dieci anni dopo), che aveva distrutto gran parte del paese, travolgendo forni, fucine, campi, e recando un terribile carestia. In tale occasione la popolazione aveva presentato al Duca di Savoia l’ennesima richiesta di remissione delle tasse. E poiché le disgrazie non vengono mai sole, nel 1599 si era diffusa in valle una violenta pestilenza. Sicuramente il paese si era spopolato.
Il padre di Pietro Garino, Giacomo, doveva essere stato piuttosto benestante, se era riuscito a dare la necessaria istruzione al figlio, di cui, infatti, si è detto che risulta la firma come testimone su vari atti notarili. Ad un certo punto aveva rivestito perfino la carica di sindaco. Ora, invece, egli si ritrovava impoverito se, nel 1621, effettuando la divisione dei beni tra i due figli maschi, aveva lasciato loro una modesta casa e ben poco terreno. L’edificio fu diviso in due: a Pietro un “casiamento” con stalla, fienile e cantina; ad Antonio una “casa da fuogo” con due stanze. Per documentata segnalazione del padre stesso, i due fratelli non andavano d’accordo. Antonio, nel 1624, emigrò a Lanzo e Pietro ne rilevò i pochi averi. C’era anche una sorella, Margarita: rimasta vedova e colpita da un rovescio finanziario a causa del marito, fu poi sempre ospitata dal fratello, che doveva esserle affezionato. Nel frattempo, intorno al 1621, Pietro Garino si era anche sposato. Infatti, da un atto, risulta che egli, quell’anno, aveva acquistato “una pezza di prato, brusco, bosco” con denaro del suocero, un Venera (una delle famiglie più in vista), versato come anticipo della dote. La località del terreno è “ ‘n Rognosa” (oggi “ ‘n Rignosa”), un ripiano prativo quasi ai piedi del Santuario, appena a sinistra del ponte sul torrente. Dal matrimonio nacquero tre figlie, che poi si sposarono. Pietro provvide alla loro dote, ma, nel 1651, con un primo testamento, nominò erede uno dei nipoti, un Bonino. Morto questi prematuramente, le sostanze passarono alle figlie, con il testamento del 1660, anno della probabile morte del nostro. La condizione economica di Pietro, a tutta prima, sembra modesta, come testimonierebbe il fatto che, al pari di gran parte dei montanari dell’alta valle, egli si recasse a lavorare nella stagione invernale a Torino; tuttavia non sappiamo quali mansioni svolgesse in città né se fosse un semplice manovale o altro; potrebbe anche essersi occupato di incombenze diverse, magari da mediatore. Forse non aveva interrotto i contatti già intrecciati, quando, prima dell’inondazione, si occupava di miniere come la Rognosa. Nella capitale sabauda, comunque, affittava un’unica camera per sé e la famiglia. Proprio qui, una notte, portando da bere ad una delle figlie, che era malata, ebbe una prima visione. Su un altarino che aveva allestito vide l’immagine di una “figliuolina” bellissima, che subito sparì. Era una specie di anticipazione del miracolo verificatosi a Forno? Il 4 agosto del 1629, forse in occasione di tempi difficili, il Garino aveva compiuto il suo pellegrinaggio al Rocciamelone, una delle mete “cult” della religiosità di allora e probabilmente oggetto di venerazione già in epoca pagana. Qui trovò per caso due sacri quadretti, che sono all’inizio di tutta la sua vicenda. Quando tornò a Forno con la famiglia (mentre in pianura infuriava la peste), acquistò sul posto una casa e numerosi terreni, versando un anticipo di 800 fiorini (attestato su documenti). Questa improvvisa disponibilità di denaro, accumulata a quanto pare a Torino, rimane un punto misterioso della vita del personaggio, della quale nulla è dato di sapere, ma certo può far pensare ad una condizione non umile. Sicuramente doveva essere abbiente quando, fra il ’31 ed il ’32, fece costruire la prima cappella. Anni dopo, però, i terreni risultano venduti a poco a poco. Forse per difficoltà economiche ? Necessità di assicurare una dote alle figlie ? Comunque alcuni fatti sono certi. Malgrado il massiccio afflusso di pellegrini, e quindi di offerte, è evidente che il Garino non si arricchì grazie al miracolo della sua visione. Nemmeno fu oggetto di beatificazione, come a volte è capitato ai protagonisti di tali eventi. Occupò un posto nel consiglio di amministrazione della cappella, ma rimase in posizione defilata. Di lui, insomma, restano poche notizie relative al quotidiano, ma nulla sul prosieguo dell’evento prodigioso. Rimane quindi, come dato oggettivo, la probità del personaggio: convinto devoto, non divenne un’opportunista né tentò di arricchirsi. Lontani ormai i tempi delle attività minerarie, è probabile che a Forno conducesse una normale vita di montanaro e disponesse di bestiame. Infatti, quando ebbe l’apparizione, stava tagliando, su di un albero, dei rami di frassino, in genere usati come cibo autunnale per le capre. Non è da escludere, comunque, che si occupasse anche di altre attività. Ma i documenti non ci dicono se, dopo l’apparizione, fosse tornato a migrare a Torino. Se lo faceva, è pensabile che, come era frequente, lasciasse i suoi animali a pensione presso qualcuno del posto, forse la famiglia del nipote. Insomma il personaggio risulta circoscritto in un quadro di normalità. Dal pellegrinaggio sul Rocciamelone al Santuario di Forno La vicenda di Pietro Garino e dell’apparizione della Madonna è stata già ampiamente narrata da più parti, per cui ora la racconteremo per sommi capi, cercando però di rilevare i punti salienti. Tutto inizia con il pellegrinaggio in cima al Rocciamelone, il 4 agosto 1629. Erano momenti brutti, tali da giustificare un sacrificio del genere. Può essere anche che il Garino vi sia salito passando per la Valle di Viù; se si trovava a Forno era la via più breve, ma anche la più ardua. Sulla vetta, mentre pregava, vide per terra due quadretti, abbandonati e malconci, che rappresentavano la Madonna (attenzione: dalla pelle bianca) e San Carlo Borromeo. Alla presenza dei due compagni di ascensione, li raccolse e decise di recarli con sé per farli “accomodare”, con l’intento di riportarli , in seguito, sulla cima. Probabilmente provvide al compito di affidarli ad un pittore mentre era a Torino. Nella stanza che occupava, allestì un piccolo altare, coperto di carta bianca, e vi pose i quadretti restaurati. Ogni sabato accendeva una lampada ad olio e recitava le sue orazioni. Una notte, alzatosi per dare da bere ad una delle figlie, che era malata, come si è detto, ebbe la visione, sull’altare, di una “figliuolina” bellissima, che subito svanì. Era frutto dello stato di agitazione per la propria bambina?
Ad aprile salì a Forno per la ripresa della stagione estiva e recò con sé i quadretti. Rimase in montagna fino all’autunno. In pianura, ed anche in Val di Susa, cominciava a diffondersi la peste, per cui non era pensabile tornare sul Rocciamelone, come si era proposto inizialmente, per riportarveli. A Forno era abbastanza al sicuro: mentre in bassa valle, fino a Cantoira, imperversava il morbo, lo sbarramento armato predisposto alle porte di Chialamberto fermò l’avanzata del contagio. Ripose dunque le due sacre immagini in un’arca, legate fra loro con un nastro, ma, ogni sabato, le traeva fuori e pregava. Il venerdì 27 settembre, a mezzanotte, fu svegliato da una voce che lo chiamava, ma non rispose, per timore di qualche diavoleria (di montanari terrorizzati da richiami misteriosi sono piene le “conte”). Lo stesso fatto si ripeté nelle notti del sabato e della domenica. Inutile sottolineare che la ripetizione di un fatto straordinario per tre volte è uno dei “topos” più ricorrenti nei racconti di miracoli. Il lunedì andò a lavorare in un suo terreno (“Bruscho della Rognosa”). Nella sua testimonianza il Garino precisa di essersi trovato su per la pietraia, nei pressi di una grande roccia. Salì su un frassino per tagliare delle frasche per il bestiame. Questo tipo di albero era stato, dopo la quercia, il più importante nella cultura celtica ed era diventato oggetto di ampio utilizzo tra i montanari. Quale non fu la sua sorpresa, allorché scorse in cima all’albero i due quadretti, legati come li aveva lasciati egli stesso nell’arca. Scese, si inginocchiò a capo scoperto davanti all’albero (chissà quante volte i suoi avi avevano compiuto un gesto così pregnante) e pregò la Vergine e San Pietro (di cui portava il nome) di rivelargli chi li avesse recati lì, e subito si trovò i quadretti davanti. Li prese, se li mise sotto braccio e rinnovò la sua preghiera. Come girò il viso verso il monte, scorse, su un ripido masso, la Vergine con altre due donne. Indossava un velo verde in testa, una veste lunga coperta di gioie lucenti ed una collana di perle. Di colpo egli compì un balzo di “due trabucchi” (circa sei metri) e, “senza che sapesse come vi fosse portato”, si trovò dinanzi a loro. La Madonna aveva i piedi scalzi, bianchissimi. Soffermiamoci un instante ad analizzare la scena nelle sue componenti. In cima al frassino compaiono i sacri quadretti, uno dei quali rappresenta la Vergine. Sono nominate, nella tradizione popolare, frequenti apparizioni della Madonna stessa su un albero, pronta a dispensare le sue esortazioni e, soprattutto, a chiedere la fondazione di un edificio religioso. Sono quelle che gli studiosi chiamano “Madonne Arboree”, cogliendo in questo “topos” un revival degli antichi culti, quando le divinità, o ninfe che fossero, si identificavano con la natura, e spesso proprio negli alberi, a cui davano prosperità. Ma non manca chi fa notare che la comparsa della Vergine in un bosco sacro dai tempi del paganesimo (e tale doveva essere quello in cui si trovava il Garino) significa l’esaugurazione di esso, cioè la desacralizzazione del medesimo e la sua riconsacrazione al cristianesimo. Dunque questa apparizione di Maria proprio lì riveste un significato profondo. Di sacralizzazione doveva proprio esserci bisogno: la studiosa Ariela Robetto rileva come la leggenda segnalasse proprio in quel bosco la presenza delle masche sotto forma di orribili uccelli. Si tratta di un evidente riferimento ad antiche cerimonie pagane, che la Chiesa si preoccupò di demonizzare. La domanda è: perché dopo tanto tempo (il Cristianesimo era prevalso da secoli) si sente il bisogno di esaugurare un sito che era appartenuto al culto pagano? Intanto precisiamo che certe credenze, in apparenza estirpate, si mantengono a livello di inconscio collettivo per riemergere in forme nuove, le quali contengono il ricordo di tradizioni antiche. Inoltre quella che era indicata come sede di culti estranei, anche se questi cessano, rimane in un certo senso “maledetta”, (ecco la spiegazione della leggenda citata dalla Robetto). E’ sufficiente che subentri un fatto qualsiasi, “diabolico” agli occhi della popolazione o del clero, per far nascere l’esigenza di esaugurazione. L’immagine della Vergine con le due donne ci riporta ad un’antica credenza delle zone alpine, esistente ancora in epoca romana, quella delle Tre Matrone. Erano divinità secondarie, ma molto sentite tra la gente comune. Nell’insieme rispecchiavano, in aspetti diversi, un’unica dea portatrice di fertilità. In teoria erano state cancellate dal Cristianesimo, ma il loro ricordo, sotto altra forma, restava nella memoria delle popolazioni montanare. Ad esempio, come mi ha fatto notare la Serra, nel faldone relativo ai “miracoli” del Santuario di Forno risulta quello di una donna del posto che guarì, lungo la scala di accesso all’edificio, in seguito alla visione luminosa di tre “Donne”. A questo proposito gli antropologi parlano di “vischiosità” delle credenze, cioè del loro persistere nel tempo, talora sotto specie diverse, malgrado i tentativi ufficiali per cancellarle. Non mi è dato di conoscere l’estensione geografica di questo culto delle tre Madri, ma non doveva essere da poco. Infatti si racconta che, nel 626 d.C., anche a Costantinopoli, dopo l’invocazione del patriarca Sergio, la Madonna sarebbe apparsa, accompagnata da “due serve”, a scacciare i Persiani che assediavano la città.
Il colore verde del velo e gli ornamenti lucenti sull’abito della Madonna, a quanto emerge da vari studi, sono elementi caratterizzanti, a suo tempo, l’immagine della dea Iside. Come vedremo, il culto di quest’ultima, originaria dell’Egitto, si era esteso nel bacino del Mediterraneo e si era “fuso”, nell’immaginario popolare, con altre divinità antiche come Demetra e Cibele e persino con la Madre Terra dei Celti. Per capire questo complesso meccanismo di mescolanze e fusioni, dobbiamo pensare che le genti pagane erano molto più flessibili di noi monoteisti dal punto di vista religioso, e più facilmente disposte ad accettare nuovi culti intrecciandoli con i propri. Solo per fare un esempio, basti pensare alla polisemicità di una dea come Ecate, a cui gli antichi attribuivano i ruoli più diversi, da protettrice a mostruosa persecutrice, fino a ctonia e notturna, cosicché essa poté confondersi e diventare tutt’uno con Artemide come con Demetra o Cibele o altre deità ancora, come si rileva dagli studi degli antropologi Roberta Astori e Nicola Serafini. Con l’avvento del Cristianesimo le dee pagane erano state cacciate e riassorbite nella venerazione della Vergine, ma i ricordi, almeno inconsci, permanevano, restava l’uso (ormai distaccato dalle sue origini) di amuleti, gesti, espressioni verbali. Con questo il Garino, lungi dal vedere Iside nella Madonna, nel suo racconto non faceva che utilizzare stereotipi culturali di antica provenienza e radicati nella mentalità popolare da secoli. Anche la presenza sulla scena dell’albero e del masso sono stereotipi. E altrettanto si può dire del balzo inconsapevole, stile Jessie Owens, con cui Garino si trovò proiettato davanti alla Madonna: un altro “topos” dei racconti del “meraviglioso”. In conclusione la scena dell’apparizione costituisce un insieme di “topoi”, di elementi appartenenti ad una sorta di “casellario”, che condizionava la mente delle genti di allora nella percezione del “miracolo”. Non possiamo, però, ricondurre univocamente tutti i “topoi” presenti nell’apparizione di Garino ad un’unica tradizione celtica, poiché in realtà questa risulta estremamente composita, formata da elementi posti su piani cronologici e culturali diversi. Per fare un esempio terra terra: le tre Madri (la triade vista da Garino) ed Iside (il mantello verde) appartengono a mondi differenti, raccolti sincreticamente nella mentalità montanara antica. Un’ultima precisazione, ma importantissima. La Madonna ha i piedi bianchissimi, come peraltro è la sua pelle nel quadretto del Rocciamelone, e una delle donne accanto a Lei è bionda. Non c’è traccia di “nero”. Tale colore verrà dopo, e cercheremo di vedere come. La Vergine rivelò a Garino di essere la Madre di Dio e lo invitò, prima di parlare della visione con chiunque altro, a rivolgersi al proprio curato, o ad altro religioso, affinché incitasse il popolo ad invocarla solennemente ogni sabato nella Messa, se volevano che Lei intercedesse presso il figlio Gesù, per porre fine alla Sua ira, che era all’origine del contagio. Un’esortazione che rispecchia con evidenza un indirizzo religioso di matrice gerarchica. Pietro ebbe il coraggio di chiedere se il futuro avrebbe riservato pace o guerra, e la Vergine lo confortò al riguardo. Egli, allora, obiettò che temeva, diffondendo tale messaggio, di non essere creduto o addirittura deriso dai compaesani (timore più che legittimo e denso di pericoli), ma Maria lo rassicurò sbrigativamente: in tal caso “chi non vorrà credere li farò creder io”, e dopo averlo benedetto svanì. Ormai era notte e il Garino rientrò a casa. L’indomani si recò alla chiesa parrocchiale (si presume a Groscavallo) e rivelò tutto al suo curato, il quale, successivamente, informò i cappellani dei vicini paesi di Bonzo e Chialamberto. Con loro si recò a Forno in cerca del Garino, che però era tornato a lavorare nel posto del giorno prima. Raggiuntolo, si fecero mostrare da lui il punto esatto della visione. Quando tornarono a Forno, il sacerdote avrebbe voluto custodire i quadretti nella chiesa, ma Pietro insistette per tenerli presso di sé, fino a che i superiori non avessero preso una decisione definitiva. Andarono a casa sua e, insieme, rinchiusero le sacre immagini in un’arca. L’indomani, venuto a Forno per la Messa, il parroco si fece di nuovo narrare, con mille raccomandazioni, il fatto miracoloso. Quindi chiese al nostro protagonista di portargli, l’indomani, i quadretti a Campo della Pietra (una borgata più a valle di Forno), dove avrebbe celebrato Messa nella cappella di San Rocco.
Quella notte, svegliatosi, Garino estrasse i quadretti dal loro contenitore, li baciò devotamente e li ripose di nuovo, legati fra loro, sotto chiave. Il giorno successivo, inginocchiatosi per pregare, vide il nastro posato sul coperchio dell’arca. Pensando che le sacre immagini fossero state rubate, si precipitò dal parroco a Campo della Pietra per narrare l’accaduto. Allora tutti si mossero, dietro al sacerdote, per raggiungere il luogo dell’apparizione. Lì videro i quadretti, appoggiati al masso, adorni di due rami di nocciolo (elemento di significato simbolico). La commozione fu enorme e l’eco del miracolo si diffuse dappertutto. I racconti relativi alla fondazione di nuove cappelle o santuari traboccano di prodigi del genere. L’apparizione della Vergine o di un Santo o il ritrovamento di una reliquia, statua, effigie, inducono il clero a predisporre un sito di custodia o a procedere alla costruzione di un pilone o cappella, ma il materiale preparato allo scopo, di notte, viene misteriosamente trasportato sul luogo del precedente ritrovamento. La leggenda è tale persino per la Sacra di San Michele. Allora tutti si convincono a rispettare la divina volontà. E’ il caso dei quadretti, che verranno ospitati nella cappella fatta costruire dal Garino nel luogo del miracolo. Questo “topos” si può anche interpretare come volontà, da parte della Chiesa, di cristianizzare un sito pagano, creando i presupposti dell’intervento attraverso il presunto miracolo. Il curato fece poi pronunciare da Pietro, alla presenza di numerosi testimoni e addirittura di un notaio, una deposizione formale sugli eventi miracolosi. In ginocchio, a capo scoperto ed a mani giunte, Pietro Garino ripeté il suo racconto, che fu messo per iscritto in più copie, una delle quali conservata dal notaio stesso. Benché non se ne abbia documentazione ufficiale, la questione dovette poi passare al vaglio del vescovo di Torino. Un pronunciamento del Concilio di Trento del 1563 recita: “Non è lecito a nessuno ... ammettere nuovi miracoli o accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l’approvazione dello stesso vescovo”. Nel clima di rigoroso rispetto delle regole che incombe sulla vicenda di Pietro Garino le cose devono essere andate per forza così. L’impressione immediata che si trae da tutta la vicenda vissuta dal protagonista, oltre alla sua profonda devozione, che trova il suo acme nel pellegrinaggio al Rocciamelone, è appunto di un’attenzione costante e precisa a che ogni atto fosse conforme alle regole ecclesiastiche. Fin dall’inizio Garino, di fronte alla Vergine, chiede garanzie, si cautela nel timore di essere deriso, ma, secondo me, non solo di quello. Appena possibile si reca dal parroco per relazionare e, rispettando il dettato della Madonna, si guarda bene dal rivelare ad altri la propria esperienza. Non grida al miracolo. L’eco popolare verrà solo successivamente, davanti al nuovo prodigio. Il curato lo sottopone a stringenti e ripetuti interrogatori, sino alla narrazione finale alla presenza di testimoni e notaio, e Pietro vi si sottopone in totale obbedienza. Erano tempi di Controriforma e bisognava andarci cauti. Poteva sempre scapparci un processo per eresia o stregoneria. Tanto per fare un esempio, allorché si era verificata, in Lombardia (al Bosco Burone), l’apparizione di una Madonna “arborea” con grande afflusso di persone, San Carlo Borromeo non aveva esitato a far tagliare l’albero, in quanto simbolo pagano, non riconoscendo la liceità della visione. Perciò, anche nel caso di Forno, la Chiesa ufficiale avrà avuto cura di tenere sotto controllo l’intera vicenda. E’ come se l’istituzione locale, preoccupata di provvedimenti dall’alto, dichiarasse all’autorità: “Guardate che tutto si è svolto secondo le regole”. Resta tuttavia un elemento di dubbio: poco tempo dopo l’archivio del notaio presente alla deposizione fatta da Garino prese fuoco e andarono distrutti proprio i documenti relativi a quell’evento. Non risulta molto agli atti circa l’iter burocratico seguito alla deposizione scritta. Sappiamo solo che Pietro dovette recarsi a Torino dal Vescovo per ulteriori precisazioni: esiste negli archivi, mi precisa Maria Teresa Serra, la documentazione del pagamento delle spese della sua trasferta. Ignoriamo, invece, se e in che misura Roma sia stata informata, visto che non c’è notizia di un riconoscimento ufficiale. Sappiamo che nel 1631-32 il Garino fece costruire una cappella nel posto dell’apparizione e che il curato, al termine dei lavori, inoltrò una supplica, affinché gli fosse consentito di procedere alla benedizione del sacro edificio, cosa che gli fu regolarmente accordata. Da una visita pastorale dell’arcivescovo risulta che nel 1674 esisteva ancora l’originaria chiesetta , con un unico altare adorno di ex-voto. Ma nella successiva visita del 1730 si fa cenno alla presenza di una statua lignea di Nostra Signora di Loreto, cioè un’effigie in nero. E qui il discorso si complica. Considerazioni storiche sul colore nero Il tema del nero è piuttosto complesso, poiché si tratta, secondo gli studiosi di un colore notevolmente polisemico, cioè implicante variazioni e sfumature di significato. Intanto l’antropologo Michel Pastoureau rileva come, in antico, nel mondo latino come in quello germanico, esistessero almeno due tipi di nero, quello brillante (niger, black), rivestito di una valenza positiva, e quello torbido (ater, schwartz), percepito invece negativamente, potremmo dire semplicemente come “scuro”: una dicotomia scomparsa poi nel corso del tempo con la conversione su di un unico termine. Il colore nero, comunque, restava legato alle tenebre ed alla morte, ma, a seconda dei tempi e dei luoghi, cambiava il modo in cui era vissuto nella società. In Medio Oriente ed in Egitto, dove si erano diffusi i culti dedicati alla Madre Terra, era sentito come benefico, in quanto si identificava con il limo, che fecondava i campi. Pensiamo addirittura che, nel paese del Nilo, il colore temuto era invece il rosso. Perciò, quando non si trattava di viva roccia, uno strato di nero rivestiva comunque simulacri e statuette votive di divinità come Iside, Cibele, Ecate. Come tale era associato al sacro, alle caverne, cioè ai più antichi luoghi di culto dell’uomo. Il nero significava allora, per il defunto, una promessa di ritorno alla Madre e di rinascita: insomma da un lato simboleggiava, paurosamente, le tenebre, il caos, dall’altro il grembo materno della grande Dea e quindi rassicurava.
Anche per i Greci ed i Romani tale colore era associato alla morte e all’Ade. Presente nei rituali funebri sotto forma di oggetti ed offerte, nel II secolo a.C. passò a caratterizzare la toga dei magistrati durante i funerali. In età imperiale l’uso si generalizzò, ma gli abiti da lutto indossati erano più scuri che neri, di una tonalità grigio-bruna. Il fatto è che, allora come poi nel Medioevo, i tintori avevano non poche difficoltà a realizzare un nero come si deve (stessa cosa per il bianco), onde una varietà di tinte e sfumature. Tuttavia la connotazione del colore non era ancora del tutto negativa. Aristotele, nel trattare il tema dei quattro elementi che compongono il nostro pianeta, cioè acqua, aria, fuoco e terra, aveva identificato quest’ultima con il nero, e tale indicazione rimase praticamente immutata fino al Medioevo, senza che vi si implicassero connotazioni funebri o simili. Nell’Antico Testamento le tenebre precedono la luce, che esplode come un trionfo dell’atto divino e viene associata poi a Gesù. Nel Cristianesimo si elogerà proprio la luce, prima ancora del bianco. Il nero delle tenebre diventa quindi la sua negazione e nel Medioevo verrà associato al demonio. Siamo dunque in presenza di una svolta. Che nella Bibbia il nero sia una negatività morale è già evidente nell’episodio del Diluvio, nella figura del corvo, egoista e traditore, animale impuro, a cui si contrappone la bianca colomba. Ma presso i popoli germanici, ad esempio, il corvo, dal piumaggio nero brillante, era uno degli animali più venerati, caro ad Odino, per cui era consuetudine portarne l’immagine propiziatoria sulle armi. Il primo Cristianesimo riprese la dicotomia corvo-colomba in chiave metafisica, come opposizione tra male e bene, ed identificando il primo con il demonio. Quest’ultimo, per alcuni secoli, non ebbe una fisionomia fissa, ma cominciò ad acquisirla dopo il Mille, ed il colore assegnatogli fu ovviamente il nero, spesso associato al rosso (il quale caratterizzerà le fiamme dell’inferno). Detto tra parentesi, più avanti nel tempo comparvero anche diavoli verdi, per ostilità verso i Musulmani, per i quali tale colore era l’emblema del Profeta. Se il nero veniva ormai identificandosi totalmente con il male, tuttavia tra l’XI ed il XII secolo riuscì ancora a conservare una flebile traccia di positività. Infatti esso fu scelto dai monaci cluniacensi per le loro tonache come simbolo di umiltà e penitenza. Di fronte ad una nobiltà e ad una gerarchia ecclesiastica che amavano esibire vistosamente il colore, il nero della terra era segno di virtù. Ricordiamo che San Francesco sceglierà il saio, di ruvida stoffa grigio-bruna, e si farà seppellire nella nuda terra. San Bernardo di Clairvaux, che, a quanto sembra, non amava il nero, ma il bianco come simbolo di purezza, entrò in forte polemica con il cluniacense Pietro il Venerabile: questi criticava l’uso del bianco, colore delle feste religiose più importanti, come espressione d’orgoglio , l’altro vedeva nel nero il segno del male. La controversia durò fino alla metà del XII secolo. Ma all’inizio i cistercensi di Claivaux erano chiamati “grisei”, cioè grigi, per il loro colore che non riusciva ancora ad essere bianco. Il Pastoureau, infatti, ha messo in evidenza le difficoltà tecniche dei tintori di allora a migliorare i loro risultati per entrambi i colori. Perciò non dobbiamo stupirci se sotto l’etichetta di “nero” rientravano il grigio ed il bruno nelle loro varie gradazioni, e perfino il blu. Per quanto concerne le Madonne, quindi, molte saranno state brune, in relazione al legno usato per le sculture, tipo il cedro o addirittura l’ebano, e il nero vero e proprio dovrebbe essere venuto parecchio dopo (insieme a nuovi materiali, come la terracotta o il gesso), frutto di apposite ridipinture. Questo così discusso nero riacquisterà una propria dignità molto più tardi. Ai tempi della Riforma Evangelica, i Calvino, i Melantone, gli Zwingli, nemici del colore e della policromia in campo ecclesiastico in quanto segno di “vanitas”, li cacceranno dalle chiese e dagli abiti, nei quali proprio il nero tornerà a prevalere come simbolo di probità. 1 - Continua |
 -->
-->